Sommario:
- I primi di novembre: una svolta nel ciclo annuale
- Le zucche intagliate

- Riti di accoglienza, propiziatori e difensivi
- Il "dodekaemereon"
- Le questue
- I cibi tradizionali
Non molto tempo fa in un forum di neopaganesimo si parlava di Samhain, il capodanno celtico, considerato dalle Streghe come una delle feste più importanti. Una ragazza intervenne definendosi "anti-Halloween", poichè la festa è troppo commerciale per i suoi gusti.
La sua osservazione non mi stupì più di tanto: negli ultimi anni in Italia c'è stato il boom di questa festività che la maggior parte delle persone crede sia stata importata dagli Stati Uniti, e ci si limita a vederla come se fosse un moderno carnevale, svuotato di tutti i suoi significati, in cui i bambini si travestono con costumi ispirati ai vari film horror e splatter e girano per le case dicendo "dolcetto o scherzetto"...
A quanto ho sentito persino molti insegnanti d'inglese ne parlano agli alunni come fosse una festa americana ed esclusivamente mondana, senza degnarsi di approfondirne le origini storiche e religiose precristiane.
In realtà Halloween è una festa molto più antica, e persino molto più italiana di quanto non si pensi... E' questa la scritta che appare sulla copertina di "Halloween. Nei giorni che i morti ritornano", un libro meraviglioso, scritto da Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi, edito da Einaudi.
Molti già conoscono le origini celtiche e la dinamica con cui Halloween è stata esportata negli Stati Uniti e con cui in seguito, sotto le spoglie di un evento puramente mondano, ha fatto ritorno in Europa e in Italia: prima che si affermasse il cristianesimo, la festività si chiamava Samhain ed era il capodanno tipico della religiosità celtica. Cadeva nel periodo in cui, conclusa la stagione dei raccolti, ci si preparava ad affrontare la parte fredda dell'anno, ed era principalmente dedicato al culto dei defunti. Con l'avvento del cristianesimo, a Samhain vennero sovrapposti i festeggiamenti dedicati a tutti i santi (Ognissanti), e si stabilì che la commerorazione dei defunti fosse una celebrazione ad essi secondaria. Halloween significa appunto "Sera di Ognissanti", ed è la contrazione di "All Hallows evening".
La festa fu importata negli Stati Uniti da emigranti irlandesi e scozzesi, e prese piede presso il nuovo mondo trasformandosi poi gradatamente nell'avvenimento mondano che tutti conosciamo.
Ma le sue vere origini potrebbero essere anche preceltiche. Il motivo per cui certe usanze (come quella di intagliare rape e zucche per farne lanterne, come le questue giocose di bambini e mendicanti e la dedicazione dei primi giorni di novembre al culto dei morti) si potessero riscontrare anche in vaste aree dell'Europa e dell'Italia che non vennero mai contaminate in modo significativo dalla cultura celtica, è da ricercare proprio nelle basi di questa interessante teoria.
Riassumerò alcune delle argomentazioni principali con cui Baldini e Bellosi ci portano a riconoscere nelle antiche tradizioni del nostro Paese le vere antenate dell'Halloween odierna.
I primi di novembre: una svolta nel ciclo annuale
In tutte le zone in cui la cultura agropastorale è preponderante, i primi di novembre segnano lo spartiacque stagionale fra la metà dell'anno in cui il clima è mite e quella in cui il clima si fa più rigido.
Ai primi di novembre la stagione del raccolto è ormai terminata e i prodotti sono stati
 immagazzinati; gli armenti sono stati già da tempo ricondotti dai pascoli estivi sulle alture, fin nei villaggi, al riparo dal freddo; le ore diurne durano sempre meno, e si sente il desiderio di raccogliersi all'interno delle case, nell'atmosfera accogliente e rassicurante del focolare domestico.
immagazzinati; gli armenti sono stati già da tempo ricondotti dai pascoli estivi sulle alture, fin nei villaggi, al riparo dal freddo; le ore diurne durano sempre meno, e si sente il desiderio di raccogliersi all'interno delle case, nell'atmosfera accogliente e rassicurante del focolare domestico.Per tale motivo, con l'arrivo dei primi freddi, il pensiero va anche agli Antenati, che vengono accolti in casa con motivi tipicamente tradizionali: in molte regioni del nord-Italia, per esempio, era usanza aggiungere un posto a tavola, una sedia vuota destinata al caro defunto che avesse voluto condividere la cena con i parenti ancora in vita.
Un altro dei motivi per cui il Culto dei Morti assume una grande importanza, in particolare nelle zone dove si coltivano cereali, è che il periodo fra ottobre e novembre è quello in cui avviene la semina, e la speranza di un buon raccolto viene affidato alla dimensione sotterranea, nel grembo della terra in cui trovano dimora le divinità ctonie e gli stessi defunti.
Ecco che allora prendono forma i riti propiziatori con cui ci si assicura un raccolto abbondante per l'anno che verrà.
Destinatari e protagonisti di questi riti sono proprio i morti: anch'essi, come i semi, sono nella dimensione sotterranea in attesa di tornare a far parte del ciclo della vita (indipendentemente che si parli di reincarnazione, di cicli biologici o di rinnovamento dal punto di vista generazionale).
 Bisogna considerare che i morti, nella tradizione e nel folklore, sono da sempre stati considerati entità ambigue.
Bisogna considerare che i morti, nella tradizione e nel folklore, sono da sempre stati considerati entità ambigue.Nel Culto dei Morti vengono celebrati sia gli Antenati, sia i morti in generale, temuti proprio perchè ormai fanno parte di una dimensione che, dal punto di vista empirico, per i vivi è ancora estranea.
Durante la notte si temeva di incontrare anime di persone morte di morte violenta, o anime che ancora vagavano per i villaggi, impossibilitate a lasciare la nostra dimensione terrena per via di qualche torto subìto o perpetrato in vita, o comunque per qualche conto lasciato in sospeso.
Questa credenza si può ricollegare all'antica immagine della "Caccia selvaggia", rintracciabile già nel Basso Medioevo, per cui si pensava che le anime di persone morte prematuramente non trovassero una precisa collocazione nell'Aldilà, e che fossero condannate a vagare in eterno riunite in una sorta di schiera volante che travolgeva tutto ciò che trovava sulla sua strada, urlando e sibilando in modo spaventoso.
Questo mito, nonostante gli sforzi da parte della Chiesa che cercò di collocare le anime inquiete nel purgatorio, sopravvisse fino agli inizi del ventesimo secolo, e restò diffuso soprattutto nelle credenze dei montanari delle Alpi.
Ecco che allora le usanze tipiche della tradizione di Ognissanti in Italia assumono tutte un duplice significato: quello devozionale, e quello di placare le entità incontrollabili impersonate dai morti, che nel periodo di novembre, quando i confini fra la dimensione terrena e quella ultraterrena sembrano assottigliarsi, tornano a farci visita nelle nostre case.
Vediamole una per una.
Le zucche intagliate
 Nell'usanza di intagliare le zucche, dando loro un aspetto insieme grottesco e rassicurante (una lanterna allegra e luminosa nella forma di un teschio stilizzato) possiamo già riconoscere un rito apotropaico, atto cioè ad allontanare le presenze più inquietanti e paurose con la loro stessa rappresentazione.
Nell'usanza di intagliare le zucche, dando loro un aspetto insieme grottesco e rassicurante (una lanterna allegra e luminosa nella forma di un teschio stilizzato) possiamo già riconoscere un rito apotropaico, atto cioè ad allontanare le presenze più inquietanti e paurose con la loro stessa rappresentazione.Nel libro vengono riportate testimonianze varie che confermano che la zucca-lanterna di novembre (una variante era la rapa-lanterna) era già diffusa in molte regioni italiane, sia al nord che al sud, ancora prima che in America venisse importata Halloween.
Parlando con i miei suoceri (il signor Mario è piemontese, la signora Costanza è sarda), ho avuto conferma che sia in Piemonte sia in Sardegna la notte di Ognissanti si mettevano dei lumini alle finestre perchè i cari defunti potessero trovare la via di casa.
Chi decideva di utilizzare la zucca-lanterna lo faceva sia per far luce ai propri Antenati, durante il loro viaggio di ritorno, sia per scacciare gli "spiriti vendicativi", considerati molesti e pericolosi.
Spesso le zucche intagliate venivano lasciate di notte ai bordi dei campi, sui muretti e vicino ai crocicchi: si diceva che servissero a spaventare le streghe e gli spiriti malvagi, ma il più delle volte a esserne terrorizzati erano gli stessi viandanti che passavano di lì!
Dopo la festività le zucche venivano distrutte per simboleggiare la cacciata delle forze inquietanti che avevano rappresentato, e la loro distruzione veniva accompagnata da rumori di vario genere, come grida allegre, canti e scampanii.
Riti di accoglienza, propiziatori e difensivi
Nelle campagne italiane erano inoltre diffusi i riti di accoglienza per i defunti, come quello di aggiungere un posto a tavola o di lasciare cibo e bevande sul tavolo all'ora di andare a dormire, o come quello di lasciare il focolare acceso durante la notte e di alzarsi prestissimo la mattina del 2 novembre per cambiare le lenzuola dei letti in modo da far posto ai defunti che tornavano a riposarsi dopo il loro lungo viaggio dall'eternità.
Anch'essi hanno un duplice significato: oltre alla dimostrazione di affetto e di devozione da parte dei vivi, l'accoglienza veniva vista come un rituale di scongiuro, e innumerevoli erano le precauzioni da prendere per evitare eventuali ritorsioni da parte degli stessi defunti: bisognava, per esempio, evitare assolutamente di "ferire" il pane con forchette e coltelli (onde evitare di essere a propria volta feriti, anche mortalmente), o di alzarsi dal letto durante la notte, perchè l'incontro con le anime trapassate, anche se appartenenti ai propri antenati, poteva essere pericoloso per la propria incolumità.
Sempre mia suocera, la signora Costanza, mi diceva che quand'era piccola lei e le sue sorelle avevano terrore di alzarsi durante la notte, perchè temevano di incontrare qualche familiare defunto che era tornato a casa per mangiare gli avanzi che la loro mamma aveva lasciato in cucina.
Il "dodekaemeron"
Nel loro libro Baldini e Bellosi mettono in evidenza come, nonostante il calendario liturgico avesse fissato la data della commemorazione dei defunti al 2 di novembre, nelle campagne il culto dei morti e i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo ciclo annuale si estendevano in realtà in un arco di tempo che andava dal primo di novembre a quello che poi venne identificato con il giorno di San Martino.
Dodici giorni in cui, oltre ai cambiamenti climatici, si verificavano anche le scadenze dei fitti agrari, i rinnovi dei contratti di mezzadria e i traslochi rurali; dodici giorni che, oltre ai riti
 propiziatori di vario genere, venivano anche considerati ideali per varie pratiche di divinazione, come l'osservazione del fumo dei falò con cui si bruciavano le sterpaglie, o l'usanza di nascondere monetine nei dolci tipici, o la credenza che gli stessi defunti si riunissero intorno al desco per parlare del futuro della famiglia.
propiziatori di vario genere, venivano anche considerati ideali per varie pratiche di divinazione, come l'osservazione del fumo dei falò con cui si bruciavano le sterpaglie, o l'usanza di nascondere monetine nei dolci tipici, o la credenza che gli stessi defunti si riunissero intorno al desco per parlare del futuro della famiglia.In quest'arco di dodici giorni, insieme all'atmosfera raccolta e inquietante ispirata dal culto dei morti, si sovrapponeva anche quella più spensierata e carnevalesca dei festeggiamenti per il rinnovamento stagionale.
E in particolare nel giorno di San Martino, in molte regioni d'Italia si organizzavano nelle piazze giochi e scherzi di vario genere.
Il signor Mario racconta che in Piemonte, per la gente meno abbiente che non poteva permettersi un granaio, c'era l'usanza di raccogliere il granturco in una delle stanze della casa, in cui durante le serate di novembre le famiglie e gli amici si riunivano per sgranare le pannocchie, e dopo essersi raccontati qualche storia di paura, tutti bevevano vino novello e si scambiavano i pettegolezzi di paese, ridendo, scherzando e prendendosi in giro a vicenda.
Questo periodo di dodici giorni è definito "dodekaemeron", una sorta di sospensione magica del tempo che, nelle tradizioni delle antiche civiltà rurali, si ritrovava ogni volta che si verificava una svolta nel ciclo annuale, e che ha lasciato il suo segno inequivocabile anche una volta affermatosi il calendario liturgico.
Le questue
Le questue rituali, comuni a molte altre festività, erano un'altra delle peculiarità della notte di Ognissanti.
Gli autori del libro le distinguono in questue attive, dove i bambini e i poveri, in qualità di rappresentanti dei defunti, facevano il giro delle case del villaggio per chiedere pane, fave e legumi bolliti o piatti di minestra, e questue passive in cui i generi alimentari venivano lasciati, sempre per onorare i defunti, come offerta in qualche luogo pubblico o di passaggio.
Ancora la signora Costanza mi raccontava che lei e i suoi amichetti andavano in giro per i rioni, a bussare di casa in casa gridando "Ai Morti! Ai Morti!", e qualcuno offriva loro mandarini, papassini e castagne bollite, qualcun altro invece gettava in testa ai piccoli visitatori dei catini d'acqua fredda.
Una mia amica di origine siciliana mi ha detto che invece dalle sue parti la sera di Ognissanti è usanza lasciare in un angolino della casa le scarpe vecchie dei bambini, per poi fargliene trovare un paio nuovo la mattina seguente, pieno di dolciumi e caramelle, che rappresentano un omaggio da parte dei defunti.
Anche nel libro c'è un riferimento a questa usanza, una sorta di questua passiva presente non solo in Sicilia, ma anche in altre parti del Sud Italia. Secondo la tradizione, gli Antenati premierebbero così i bambini che si sono comportati bene, e questo simboleggia l'atteggiamento protettivo che essi hanno nei confronti dei più piccoli.
I cibi tradizionali
 Gli autori si soffermano anche ad analizzare la simbologia dei cibi tipici della tradizione nostrana (le fave e i ceci bolliti sono considerati il "cibo dei morti" per eccellenza) e dei dolciumi, che con i loro nomi particolari, come gli "ossi di morto" in Romagna (qui a Borgomanero si chiamano "ossa da mordere", mia mamma me li comprava sempre quand'ero bambina), sono densi di significato simbolico: mangiare in senso figurato una parte anatomica del defunto significa entrare in comunione con le potenti divinità manistiche che esso rappresenta, e nello stesso tempo riportarlo in vita attraverso il proprio corpo.
Gli autori si soffermano anche ad analizzare la simbologia dei cibi tipici della tradizione nostrana (le fave e i ceci bolliti sono considerati il "cibo dei morti" per eccellenza) e dei dolciumi, che con i loro nomi particolari, come gli "ossi di morto" in Romagna (qui a Borgomanero si chiamano "ossa da mordere", mia mamma me li comprava sempre quand'ero bambina), sono densi di significato simbolico: mangiare in senso figurato una parte anatomica del defunto significa entrare in comunione con le potenti divinità manistiche che esso rappresenta, e nello stesso tempo riportarlo in vita attraverso il proprio corpo.L'Halloween importato dall'America degli ultimi dieci-vent'anni, invece, non ha dolci tipici, se non quelli anonimi di produzione industriale.
Nella prima parte del loro meraviglioso libro-viaggio Baldini e Bellosi approfondiscono dal punto di vista antropologico tutti gli aspetti di questi dodici giorni speciali, mentre nella seconda parte ci portano a conoscere tutte le tradizioni nostrane esplorandole regione per regione, fra usanze tipiche, storie, leggende, da quelle tipicamente montane a quelle di mare, in un excursus davvero appassionante fra racconti di paura e rimembranze di una festa che in realtà ci appartiene da millenni...
E' strano però: qualche giorno fa, quando vidi che l'anziana proprietaria del negozietto di via Sant'Antonio (la frazione di Fontaneto d'Agogna dove abito io) vendeva marschmallows a forma di zucca e dolcetti a forma di fantasma, le chiesi se ricordasse come una festività simile ad Halloween già esistesse dalle nostre parti, tanto tempo prima. Lei mi rispose:"Ah, no! Questa festa è venuta di moda solo ultimamente... io prima non ne ho mai sentito parlare."
Forse ha
 risposto così perchè Halloween è diventata talmente irriconoscibile rispetto alle antiche tradizioni italiane, che a prima vista è ormai impossibile identificarla con esse e riconoscervi le nostre radici...
risposto così perchè Halloween è diventata talmente irriconoscibile rispetto alle antiche tradizioni italiane, che a prima vista è ormai impossibile identificarla con esse e riconoscervi le nostre radici... Le prima e la terza foto che illustrano questo post sono tratte dall' Album di Talba su Flickr, e s'intitolano "Pumpkin ghost" e "The Apparition". La seconda foto è tratta dall' Album di Selene Farci su Flickr e s'intitola "Valle" (ho eliminato la cornice nera perchè si accordasse con il resto delle immagini). La quinta foto è tratta dall'Album di CarloAlberto su Flickr e s'intitola "Il falò di San Michele". La sesta foto è tratta dall'Album di Degra su Flickr, e s'intitola "Ossa da mordere". La foto con le due zucche intagliate l'ho fatta io, e le zucche sono state intagliate da me e dal mio ragazzo Jimmi. L'ultima immagine è un disegno fatto con Paint da Jimmi, e s'intitola "Zukka".


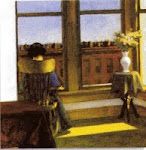






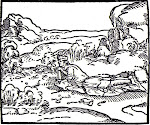






 Il nostro Sè, nei momenti in cui è lasciato libero di espimersi e di viaggiare nelle varie dimensioni spazio-temporali, è in grado di fornirci delle informazioni e dei messaggi importanti. Il sogno (come certi tipi di visualizzazioni e come i viaggi sciamanici) è uno di quei momenti. Il Sè riveste un po' il ruolo del colombo viaggiatore.
Il nostro Sè, nei momenti in cui è lasciato libero di espimersi e di viaggiare nelle varie dimensioni spazio-temporali, è in grado di fornirci delle informazioni e dei messaggi importanti. Il sogno (come certi tipi di visualizzazioni e come i viaggi sciamanici) è uno di quei momenti. Il Sè riveste un po' il ruolo del colombo viaggiatore. questo libro attribuisce questo metodo a Fritz Perls, uno psicoanalista tedesco che ha dato un notevole contributo nell' ambito della psicoterapia gestaltica.
questo libro attribuisce questo metodo a Fritz Perls, uno psicoanalista tedesco che ha dato un notevole contributo nell' ambito della psicoterapia gestaltica. Un altro personaggio importante è il fiume. In genere, nell'immaginario collettivo, il fiume rappresenta lo scorrere della vita. Ma nel nostro lavoro è importante impersonare anche un simbolo che sembra scontato come quello del fiume.
Un altro personaggio importante è il fiume. In genere, nell'immaginario collettivo, il fiume rappresenta lo scorrere della vita. Ma nel nostro lavoro è importante impersonare anche un simbolo che sembra scontato come quello del fiume. appare chiaro il presente durante la vita di tutti i giorni. Ecco perchè molto spesso si dice che i sogni rivelano anche ciò che accadrà.
appare chiaro il presente durante la vita di tutti i giorni. Ecco perchè molto spesso si dice che i sogni rivelano anche ciò che accadrà. Io l'ho piantato in giardino, accanto all'alloro, e tutti e due stanno crescendo di anno in anno: l'alloro è sempre più alto, pieno, maestoso (ho preferito lasciare che s'innalzasse come l'albero che è, invece che limitarlo al ruolo di siepe), e il rosmarino sta invadendo in larghezza gran parte dello spazio che avevo destinato alle altre aromatiche, quindi mi converrà presto ampliare i confini della rete che avevo messo per evitare che i miei cani frequentassero l'orticello (i cani sono dei veri intenditori nel campo dell'erboristeria). O, meglio ancora, potarlo in maniera radicale...
Io l'ho piantato in giardino, accanto all'alloro, e tutti e due stanno crescendo di anno in anno: l'alloro è sempre più alto, pieno, maestoso (ho preferito lasciare che s'innalzasse come l'albero che è, invece che limitarlo al ruolo di siepe), e il rosmarino sta invadendo in larghezza gran parte dello spazio che avevo destinato alle altre aromatiche, quindi mi converrà presto ampliare i confini della rete che avevo messo per evitare che i miei cani frequentassero l'orticello (i cani sono dei veri intenditori nel campo dell'erboristeria). O, meglio ancora, potarlo in maniera radicale...






 Ogni cultura ha archetipi riconducibili alle elaborazioni dei sette typos di base, e le fiabe popolari ne sono la dimostrazione.
Ogni cultura ha archetipi riconducibili alle elaborazioni dei sette typos di base, e le fiabe popolari ne sono la dimostrazione. 
 può guidare anche noi nel lungo viaggio per ritrovare le nostre radici.
può guidare anche noi nel lungo viaggio per ritrovare le nostre radici.  nelle restanti devo partecipare a certe iniziative FIM, fare la spesa, sistemare la mia casa alla bell'e meglio, preparare la cena e così via... Così sono costretta a dedicarmi a me stessa e a quello che mi piace fare durante le ore notturne. E il giorno dopo crollo. Penso che questo sia un problema di molti, vero?
nelle restanti devo partecipare a certe iniziative FIM, fare la spesa, sistemare la mia casa alla bell'e meglio, preparare la cena e così via... Così sono costretta a dedicarmi a me stessa e a quello che mi piace fare durante le ore notturne. E il giorno dopo crollo. Penso che questo sia un problema di molti, vero? Qualsiasi sia la religione a cui appartenete, dopo aver concluso quest'esercizio non dimenticate di ringraziare la nostra Madre Terra. Chi pratica Magia Naturale e chiunque sia abituato a fare esercizi bioenergetici, meditazione o Yoga può radicarsi, centrarsi e così via. Ma credo che anche un semplice ringraziamento mentale possa coronare degnamente la fine di questa pratica.
Qualsiasi sia la religione a cui appartenete, dopo aver concluso quest'esercizio non dimenticate di ringraziare la nostra Madre Terra. Chi pratica Magia Naturale e chiunque sia abituato a fare esercizi bioenergetici, meditazione o Yoga può radicarsi, centrarsi e così via. Ma credo che anche un semplice ringraziamento mentale possa coronare degnamente la fine di questa pratica. braccio destro teso in avanti. Provate in entrambe i modi, e vedete quello che vi si conface di più. Inoltre la RavenWolf non specifica di partire dall'inguine: sembra sottintendere che il movimento di sollevamento debba partire dal plesso solare. Io preferisco farlo partire dalla base della spina dorsale, perchè è lì che si trova il centro energetico che ci collega alla Terra.
braccio destro teso in avanti. Provate in entrambe i modi, e vedete quello che vi si conface di più. Inoltre la RavenWolf non specifica di partire dall'inguine: sembra sottintendere che il movimento di sollevamento debba partire dal plesso solare. Io preferisco farlo partire dalla base della spina dorsale, perchè è lì che si trova il centro energetico che ci collega alla Terra. parte ricorda molto da vicino il mito in cui Ceridwen insegue Gwion, in una continua succesione di metamorfosi, in una sfida fra alunno e maestro.
parte ricorda molto da vicino il mito in cui Ceridwen insegue Gwion, in una continua succesione di metamorfosi, in una sfida fra alunno e maestro. 
 Il Tarocco di Marsiglia, e anche la maggior parte di tutti gli altri mazzi, è formato da 78 carte, suddivise in Arcani Maggiori e Arcani Minori.
Il Tarocco di Marsiglia, e anche la maggior parte di tutti gli altri mazzi, è formato da 78 carte, suddivise in Arcani Maggiori e Arcani Minori.  Maggiori, perchè le figure sono più facili da memorizzare e i significati sono (in apparenza) più immediati.
Maggiori, perchè le figure sono più facili da memorizzare e i significati sono (in apparenza) più immediati.  Osserviamo ciò che le carte sembrano comunicarci a prima vista. Quali sono i simboli, le immagini che subito ci riportano alla nostra situazione? Cos'è che rappresenta, nel primo arcano, il nostro desiderio? E nel secondo arcano, quello sovrapposto, dov'è che possiamo individuare il vero ostacolo che ci divide dalla manifestazione del nostro scopo? Ci avevamo mai pensato? E' possibile che avessimo attribuito la causa degli impedimenti a qualcosa di più superficiale di ciò che stiamo trovando su queste immagini? O, al contrario, a qualcosa che pensavamo fosse troppo difficile per noi da affrontare? Spesso i Tarocchi ci invitano a guardare la situazione da un punto di vista nuovo, che non avevamo mai preso in considerazione.
Osserviamo ciò che le carte sembrano comunicarci a prima vista. Quali sono i simboli, le immagini che subito ci riportano alla nostra situazione? Cos'è che rappresenta, nel primo arcano, il nostro desiderio? E nel secondo arcano, quello sovrapposto, dov'è che possiamo individuare il vero ostacolo che ci divide dalla manifestazione del nostro scopo? Ci avevamo mai pensato? E' possibile che avessimo attribuito la causa degli impedimenti a qualcosa di più superficiale di ciò che stiamo trovando su queste immagini? O, al contrario, a qualcosa che pensavamo fosse troppo difficile per noi da affrontare? Spesso i Tarocchi ci invitano a guardare la situazione da un punto di vista nuovo, che non avevamo mai preso in considerazione. la base, la premessa necessaria affinchè la nostra realizzazione trovi adempimento. Quello che prima rappresentava semplicemente un ostacolo insormontabile, è diventato ora il nostro trampolino di lancio. Dobbiamo imparare a utilizzarlo come se lo fosse, approfittarne come se fosse un'occasione imperdibile per cogliere l'attimo e andare in avanti. Guardatelo come più vi piace: come un trampolino, appunto, o come un muro da scalare, una porta da aprire, o anche come un segnaletica rudimentale, lasciata da qualcuno che ha deciso di aiutarvi nel momento in cui vi siete persi nella foresta intricata della vita.
la base, la premessa necessaria affinchè la nostra realizzazione trovi adempimento. Quello che prima rappresentava semplicemente un ostacolo insormontabile, è diventato ora il nostro trampolino di lancio. Dobbiamo imparare a utilizzarlo come se lo fosse, approfittarne come se fosse un'occasione imperdibile per cogliere l'attimo e andare in avanti. Guardatelo come più vi piace: come un trampolino, appunto, o come un muro da scalare, una porta da aprire, o anche come un segnaletica rudimentale, lasciata da qualcuno che ha deciso di aiutarvi nel momento in cui vi siete persi nella foresta intricata della vita.

